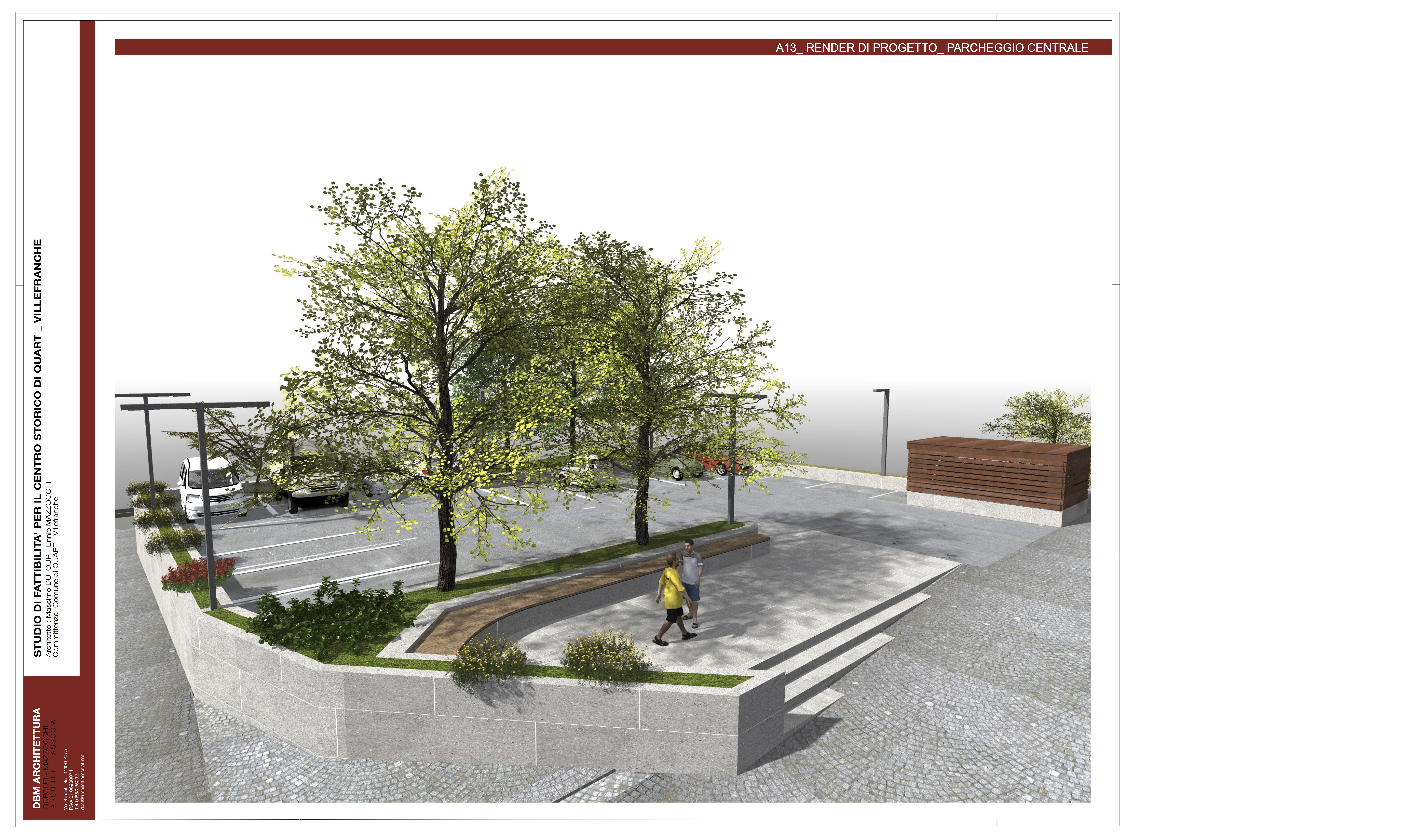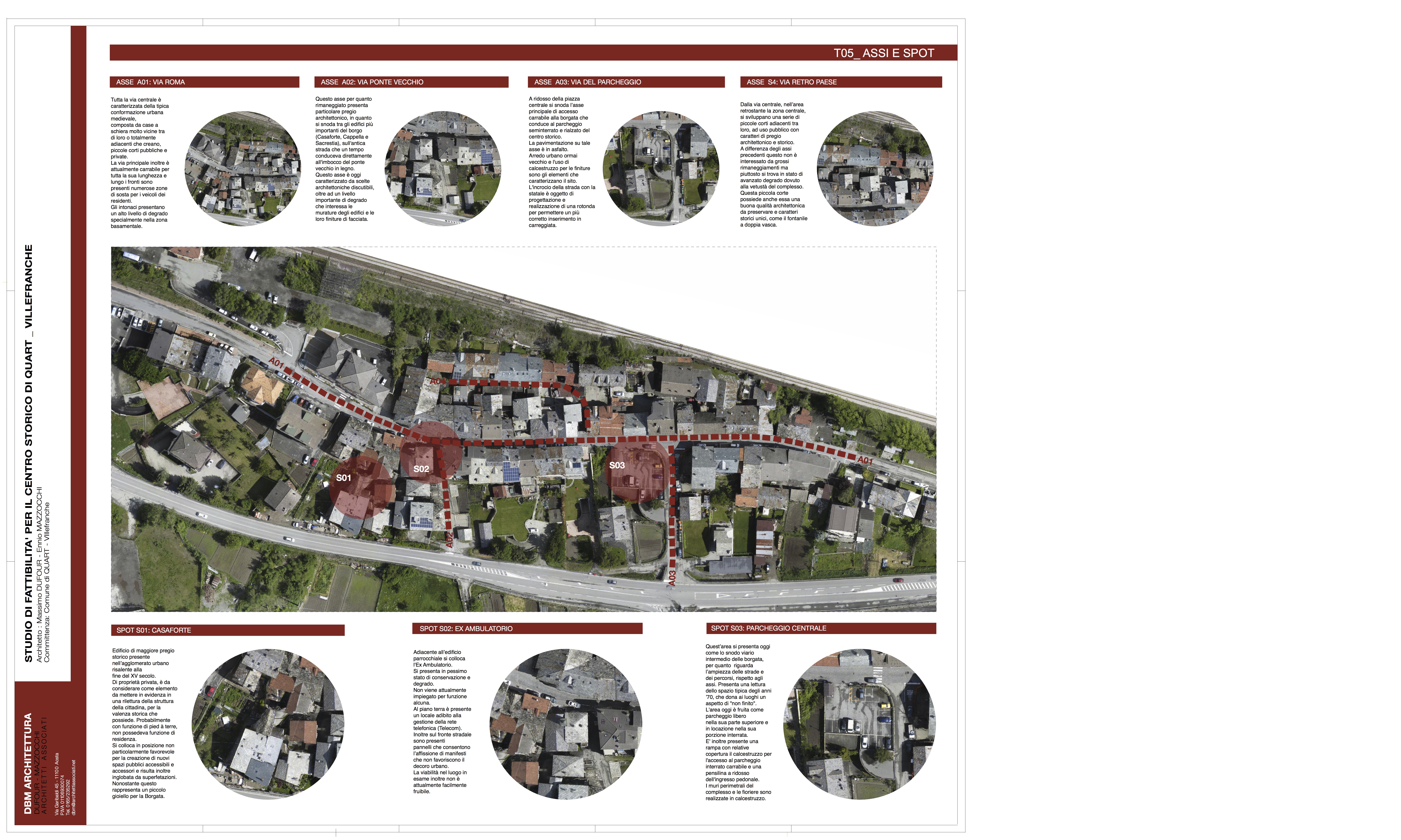Mercoledì 21 febbraio, l’amministrazione comunale di Quart incontrerà la popolazione di Quart – Villefranche per illustrare e condividere le soluzioni progettuali individuate dallo Studio DBM Architettura, sugli interventi di riqualificazione del Centro Storico di Villefranche.Sarà presente l’Architetto Massimo Dufour, capo progetto.Questa iniziativa si inserisce nelle iniziative di #opengouvernement intraprese dall’amministrazione di Quart, con il progetto “Partecipa anche Tu”.
Cenni storici sul Borgo di Villefranche:
Nel 1861 vennero trovati mattoni di origine romana e un blocco di pietra lavorato. Si ipotizza fosse un troncone di colonna risalente al periodo romano, anche se viene presa in considerazione la teoria della popolazione secondo cui essa fosse la base di un torchio antico. Si scrisse anche a proposito del soffitto a volta di una delle cascine del centro storico, dove risulta ancor oggi conservata una colonna e un capitello in pietra (già segnalata la scoperta da Napoleone nel 1811). La colonna misura 180 cm x 30 cm e si ipotizza che sia di origine romana o medievale.
La prima teoria è poco convincente in quanto numerosi pareri storici pare abbiano confermato che la strada consolare non passava per la zona, ma più in alto tra le vigne, dove risultava più agevole. A conferma di ciò non risultano segni di insediamento romano nella zona i esame. Durante il Medioevo invece la città di Quart era attraversata dalla “grande route” o “chemin royale”, che la collegava direttamente ad Aosta e proseguiva verso il Piemonte. In corrispondenza di Villefranche l’asse raggiungeva notevoli dimensioni (documentato fino al 1629). Ancora nel XVI e XVII sec. la Grande Route aveva lo stesso tracciato. Nel 1629 vi fu un’alluvione che distrusse parte del tracciato, evento che si ripeteva in modo abbastanza assiduo nella parte di valle in corrispondenza di Villefranche, ricoprendo il territorio di detriti.
Numerosi altri collegamenti erano presenti e di vitale importanza per la cittadini durante il periodo enunciato, come quello con Seran o con Chetoz.
Il ponte
Passando sopra la Dora Baltea collegava Villefranche col territorio di Brissogne. La data di costruzione non è nota ma le origini sono comunque da considerarsi molto antiche, in quanto garantiva il collegamento soprattutto commerciale tra la zona di Quart e i paesi di Fenis, Saint. Marcel e Brissogne stessa. Era l’unico collegamento presente nella zona che permettesse di oltrepassare il confine naturale, e si collocava in corrispondenza della strada che costeggia la cappella, al di fuori della cinta muraria.
I primi documenti che ne attestano l’esistenza risalgono al 1419, impiegato anche come orologio per il rifornimento di acqua per l’irrigazione, o come luogo di stipula di contratti notarili nel XV secolo. Era anche considerato luogo con una certa sacralità.
Costituito in legno fu ricostruito più volte, ed era soggetto a continua manutenzione a seguito delle copiose alluvioni, fino alla sua demolizione definitiva nel 1952 e la sua ricostruzione in cemento armato (più ad est).
Nel XVI secolo a seguito di una grave epidemia di peste venne deliberata l’adattamento del ponte a ponte levatoio per isolare la cittadina di Villefranche da un possibile contagio. La continua manutenzione richiese sforzi in denaro alla popolazione come risulta da documenti del 1623. Si assistette quindi ad una controversia tra i vari paesi a seguito dell’istituzione di una tassa sul pedaggio che servisse ai fini del mantenimento in opera del ponte stesso.
Non risultano notizie fino al 1789 anno in cui si decise di costruire un canale per far defluire le piene della Dora ed evitare l’allagamento del paese e si stanzia una “corvee” da versare per il mantenimento della struttura.
In Valle d’Aosta la definizione “borgo” è data (a differenza della definizione latina per eccellenza che definisce borgo il territorio fuori le mura) sulla base delle conoscenza attuali, a centri fortificati cintati, come avveniva per tutti i borghi del territorio in esame. I centri abitati valdostani risultano accomunati dalla collocazione che possiedono rispetto agli assi che attraversano la valle, ovvero quella di essere strategicamente raggiungibili perché lungo il percorso.
Il “borgo franco” per eccellenza era infatti luogo per richiamare l’attenzione dei mercanti allo scopo di incrementare i profitti: intorno all’agglomerato rurale si prevedeva la fortificazione per poter far sviluppare il borgo in modo idoneo. Pare che solo Villefranche rispetti questa tipologia di espansione, gli altri centri valdostani possedevano già i caratteri per definirsi “burges”, avevano già le mura o si trovavano sugli essi di maggiore importanza perché europei.
Le abitazioni anche se all’interno del borgo, erano contadine nell’aspetto e nella disposizione, anche se probabilmente realizzate in pietra e non in legno. La tipica abitazione aveva un’altezza di due piani sulla strada principale, e al posto delle stalle vi erano locali dedicati alle attività principali dell’ambiente come un laboratorio o vendita.
I borghi diventavano quindi dipendenti del mercato e luogo chiuso di scambio e incontro. Questo clima creava benessere nella zona in modo da garantire pace ed espansione del territorio fungendo da volano economico.
Quindi i caratteri fondamentali dei borghi nella Valle d’Aosta sono: la collocazione lungo la via principale, la via centrale del borgo fiorente di attività, l’ospizio, la cattedrale e la cinta muraria.
Avvenimenti importanti e decadenza
Le origini sono da ricondursi probabilmente ad un piccolo villaggio di origine rurale che per una serie di eventi non ben specificati si è evoluto in “villafranca”. La modalità con cui si è espanso ed ha assunto così tanta importanza sono da ricondursi probabilmente alla collocazione sul territorio.
Villefranche si poneva tra due centri fortificati (Quart e Brissogne) in corrispondenza di un ponte. La cinta muraria venne probabilmente eretta nel XIII secolo. Questo fu possibile grazie ad una situazione economica piuttosto favorevole agevolata dai dazi ridotti e franchigie agevolate da parte delle signorie. Inoltre i prodotti potevano e dovevano essere venduti dal borgo per il borgo in modo da mantenere l’economia del paese preservata. I secoli dal XIV al XV sono stati i secoli fiorenti per Villefranche, meta di carovane, fiere e tappa di viaggiatori. Il borgo era anche riconosciuto come sede giuridica e amministrativa intorno alla metà del Seicento.
Tra gli avvenimenti che hanno maggiormente minato il borgo vi è la grande peste del 1342 e del 1348 che decimò la popolazione e l’incendio della fine del XIV secolo.
I documenti del secolo attestano la grande ricchezza della borgata che finanziava guerre e aveva un grande rientro economico come punto di ristoro.
La decadenza di Villefranche si ha a partire dal XVI secolo, epoca che vide tutta la Valle d’Aosta superare grosse prove: furono le guerre europee a provocare la caduta definitiva della borgata, anche a causa del continuo passaggio di truppe e dei relativi saccheggi. La grande alluvione del 1629 e la peste del 1630 misero definitivamente in ginocchio tutto il territorio nel 1631. Il blocco della circolazione bloccò anche l’economia del paese a causa del divieto di muoversi e di attraversare il ponte. Nel 1639 Villefranche venne
Nel 1848 un’alluvione rese il borgo in condizioni ancora più disperate.
Nel 1853 Villefranche fu teatro di un episodio particolare detto “troisieme revolution des Socques” ovvero una rivolta contadina diretta dai conservatori e dal clero, in tutta la Valle, per l’abolizione dello Statuto Albertino e della nuova legge. In questo contesto numerosi abitanti accusarono danni e furti e vi furono scontri tra le forze dell’ordine e i cittadini.
Le mura
Circondato da mura il borgo aveva due porte principali: ad Ovest verso Aosta e a Est verso Nus. Esse sono citate già nel 1407 insieme alle mura e al fossato lungo le stesse. La porta verso Aosta è invece menzionata nel 1410 (la stessa descrizione del borgo viene data 300 anni dopo). Dalla porta ovest si accedeva alla strada che conduceva alla cappella.
Sul lato est le mura erano costeggiate da una strada che nell’angolo nord-est scendeva verso la Dora. A ridosso delle mura risultavano addossati alcuni edifici.
Sul lato sud non risultava la presenza di fossato, ma di una strada che costeggiava la Dora Baltea, le mura verso ovest, lunghe 80 metri, erano protette dal fossato dl 1410 al 1720.
Le mura nord, lunghe 125 metri, non erano addossate alla collina, ma adiacenti ad una piccola strada.
La cappella e l’ospizio
Dedicata a Saint Jacques e Saint Antoine protettori contro le calamità. Lo stesso Saint Antoine è il santo a cui è dedicato l’Ospizio, che sorgeva nei pressi della cappella. Tale cappella unitamente al castello figuravano come gli elementi di maggiore pregio e più antichi del Comune di Quart. La cappella era quindi già esistente nel 1392 e la sua fondazione pare risalga al 1271-1314, anche se non si conosce la data certa. Risulterebbe però essere una tra le più ricche e dotate di sacri arredi della Valle d’Aosta. Esistono documenti risalenti alle visite pastorali effettuate, che ne attestano le condizioni: la visita del 1436 metteva in luce la cattiva gestione dell’Ospizio e la necessità di un restauro per la cappella e per l’altare. Nel 1625 si chiese di procrastinare i restauri per mancanza di fondi ma vennero svolti i lavori fondamentali per permettere le celebrazioni. Nel 1686 si attuarono pesanti lavori di ricostruzione della cappella ormai in rovina (ex novo). Nel 1816 la comunità acquistò una nuova campana, mentre nel 1913 vennero rifatte completamente le coperture: la cappella è nuovamente in pessime condizioni, fino alla visita del 1953. Nel 1981 furono necessari lavori per la facciata, oggigiorno la cappella possiede ancora elementi di grande pregio.
Toponomastica e “iles”
Villefranche si estende nella piana tra il territorio tra Quart e Nus. La pianura è sempre stata modificata dalle acque della Dora Baltea, a causa di alluvioni: per metà del XX secolo tale territorio era punteggiato da “iles” ormai scomparse. I terreni erano periodicamente distrutti e il fiume arrivò anche a minacciare il borgo. Si attestava la presenza di piante da salice, piante spinose che davano il nome al luogo in cui si collocavano.
I terreni erano costituiti da pascoli, boschi cadui e iles ovvero terreni soggetti ad essere alluvionati.
La vita del borgo
Il nucleo abitativo si snodava lungo la via principale, che attraversava il borgo in tutta la sua lunghezza da ovest a est. Intorno alla cappella si trovavano una serie di abitazioni leggermente distaccate dal nucleo principale. I continui saccheggi e gli incendi spiegano la mancanza di elementi architettonici a testimonianza delle differenti epoche. Il borgo ospitava una popolazione molto attiva nonostante le dimensioni ridotte, la quale svolgeva ogni tipo di attività commerciale e produttiva, specialmente relativa all’artigianato con relative corporazioni (pelletteria).
Altra attività largamente diffusa era la produzione di vino e relativi servizi annessi. L’allevamento e il macello, la pesca e le fiere figuravano come altre attività di spicco sul territorio.
Grande rilevanza era assunta anche dalle attività para-industriali.
Le torri
Sulla collina vi erano due torri, che appartenevano entrambe al territorio di Villefranche. Oggi ne è rimasta in piedi solo una. A pianta circolare, la seconda torre è crollata tra il 1926 e il 1932. Non esiste una storia precisa su di esse: sono anguste e piccole quindi si suppone fossero torri di segnalazione, verso i castelli vicini. La scala all’ingresso si poteva rimuovere e si collocava a sud, ma sullo stesso fronte non vi sono altre feritoie. Sul lato nord vi sono invece tre feritoie. Si ipotizza che esse servissero per controllare il traffico e il transito. I documenti le menzionano solo nel 1401. All’uscita del borgo vi era anche un’altra torretta simile.
La casaforte
Costruito nel XV secolo ora è seminascosto tra le case. Le dimensioni e i caratteri lo riconducono a un ”piéd a terre” a funzione non residenziale, in cui il rappresentante della città esercitava le sue funzioni, come ricevimento o la redazione di documenti amministrativi. Si pensa che i piani essendo privi di aperture potessero servire come magazzino. La funzione residenziale è esclusa a causa della mancanza di camini. Può aver ospitato anche un tribunale.
BIBLIOGRAFIA
“Villefranche- storia di un antico borgo” _ Alessandro Liviero _ Musumeci Editore
“Quart – Spazio e tempo” _ A cura di Joseph-Gabriel
Rivolin.